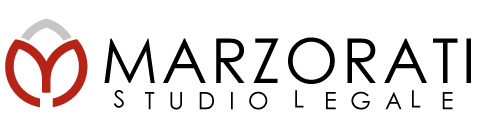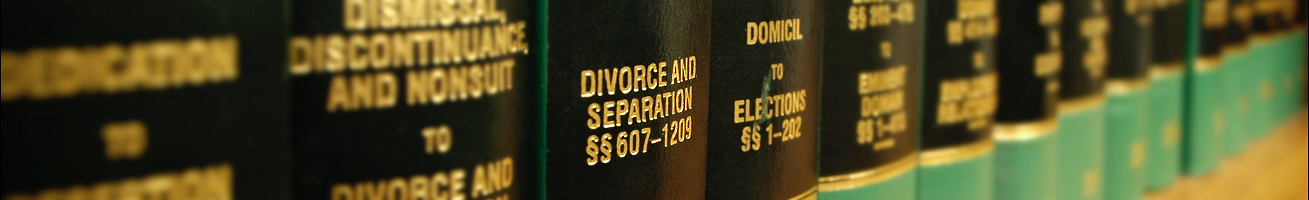Separazione
Avvocato Separazione | Studio Legale Marzorati
Separazione

Separazione – La Guida alla separazione
Separazione – Indice
- La separazione
- Separazione consensuale e giudiziale, differenza
- Tipi di separazione
- Come chiedere la separazione
- Non concedere la separazione?
- Diritti del coniuge separato
- Calcolo assegno mantenimento alla moglie
- Addebito della separazione
- Separazione con figli
- Separazione senza figli
- Differenza tra affidamento e collocazione
- Calcolo assegno di mantenimento per i figli
- Addebito e affidamento
- Separazione consensuale, procedura
- Separazione con Negoziazione assistita senza andare in Tribunale
- Negoziazione assistita dagli avvocati, tempi
- Separazione giudiziale
- Sentenza parziale di separazione
- Effetti personali della separazione
- Coniuge separato e superstite non separato
- Tribunale competente per la separazione
- Documenti per la separazione consensuale e giudiziale
- Differenza tra separazione e divorzio
- Tempo tra separazione e divorzio “breve”
- Riconciliazione
- Modifica delle condizioni di separazione
- Assistenza legale
La separazione può essere consensuale o giudiziale.
Che cosa è la separazione: la separazione è una procedura semplificata che consente ai coniugi (marito e moglie) di separarsi legalmente.
La separazione non pone fine al matrimonio, ma ne sospende alcuni effetti (non c’è più obbligo di coabitazione, fedeltà, ecc.) in attesa del successivo divorzio. Con la separazione può essere chiesto contestualmente il divorzio che viene deciso dallo stesso giudice così da ottenere una riduzione della durata delle cause.
I coniugi che si separano possono però, anche decidere di riconciliarsi o rimanere “separati a vita”.
Differenza tra separazione consensuale e giudiziale
Tra separazione consensuale e separazione giudiziale esiste più di una differenza:
- nella separazione consensuale i coniugi (marito e moglie) devono aver trovato un accordo su tutte le condizioni della separazione e si ottiene in tempi molto brevi (da poche settimane a qualche mese);
- la separazione giudiziale si ottiene dopo aver fatto una causa in Tribunale perché non si è raggiunto un accordo (o perché l’altro coniuge era irreperibile, o perché non voleva concedere la separazione). Il Tribunale emetterà una sentenza di separazione.
La separazione (consensuale o giudiziale) è una “separazione legale” perché viene emesso un provvedimento formale, e consente di chiedere il divorzio, anche durante lo svolgimento della causa.
La “separazione di fatto” si ha quando marito e moglie si lasciano senza formalizzare legalmente la situazione, tuttavia la separazione di fatto non consente di chiedere poi il divorzio (bisogna, infatti, passare per la separazione legale: consensuale o giudiziale).
Separazione insieme al divorzio con un solo ricorso con Avvocato matrimonialista
Il divorzio si può velocizzare chiedendolo insieme alla separazione, con un unico atto, e l’assistenza di un avvocato, preferibilmente un avvocato matrimonialista. Non è più necessario un ricorso per chiedere la separazione, e poi un secondo ricorso separato per ottenere il divorzio: è possibile, infatti, svolgere le due domande insieme. Per avere direttamente il divorzio immediato basterà fare una domanda cumulativa.
La separazione non viene abolita, ma in questo caso è possibile ottenere la separazione e poi il divorzio breve in modo più rapido: non si esiste quindi di un “divorzio senza separazione”.
Il Tribunale, entro 90 giorni dal deposito del ricorso da parte dell’Avvocato, fissa l’udienza per la separazione alla quale i coniugi devono comparire personalmente. Per ottenere il divorzio si devono aspettare 6 mesi, in caso di separazione consensuale, oppure 12 mesi in caso di separazione giudiziale (quando si è fatto causa). Il divorzio insieme, alla separazione, si può chiedere con la richiesta cumulativa in un unico ricorso.
Per chiedere il divorzio contestualmente alla domanda di separazione l’avvocato deve elencare subito in un unico atto tutte le domande e le prove relative alla separazione e al divorzio, il quale potrà essere pronunciato dallo stesso Giudice che lo tratta insieme alla separazione nello stesso processo.
Per ottenere il divorzio basterà:
1) che ci sia stata la separazione: anche semplicemente la sentenza “parziale” di separazione che viene emessa già dopo la prima udienza, senza dover attendere la conclusione della causa
2) che siano passati 6 o 12 mesi (rispettivamente in caso di consensuale o giudiziale). Durante questo periodo ovviamente i coniugi non devono rimettersi insieme.
La causa di separazione o divorzio giudiziale si introduce sempre con un ricorso ma gli Avvocati devono depositare al Giudice alla prima udienza già tutto quello che serve per decidere, soprattutto le prove, in modo che sia più facile (e veloce). Quindi l’avvocato dovrà subito inserire negli atti, in maniera dettagliata e completa, tutti i fatti più rilevanti e, soprattutto, tutti i mezzi di prova(documenti, ricevute, foto, testimoni ecc.).
Una sola udienza entro 90 giorni con tutte le prove e i documenti
Entro 3 giorni dal deposito in Tribunale del ricorso da parte dell’avvocato, viene fissata – con decreto – la prima udienza in cui i coniugi devono essere presenti personalmente. L’udienza è fissata in tempi brevi, ossia entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Dopo la notifica dell’atto e del decreto al coniuge convenuto, le parti avranno la possibilità – prima dell’udienza – di depositare ulteriori atti per dettagliare meglio le loro domande e prove. Quindi prima della prima udienza le parti potranno depositare ulteriori documenti e avanzare istanze istruttorie in relazione alle difese della controparte, così da dare al Giudice istruttore un quadro completo.
All’udienza il Giudice:
1) assume i provvedimenti provvisori ed urgenti (affidamento e collocazione dei figli minori, assegnazione della casa familiare, tempi e modalità di visita dei figli presso il genitore con cui non vive prevalentemente, assegno mensile per i figli, eventuale assegno di mantenimento del coniuge ecc.). I provvedimenti provvisori ed urgenti sono subito applicabili e sono sempre modificabili e revocabili e, in alcuni casi, appellabili;
2) esamina le istanze istruttorie: quindi valuta le prove e decide ad esempio se sentire, o meno, dei testimoni, se far fare ad uno psicologo di sua fiducia (Consulente Tecnico d’Ufficio c.d. CTU) una consulenza per l’affidamento dei figli o per studiare i redditi/guadagni dei coniugi anche se sospetta non siano stati dichiarati. (in questo caso può essere supportato anche da una indagine fiscale della Polizia tributaria o della Guardia di Finanza ecc..)
Nella separazione e divorzio giudiziale i figli – per i provvedimenti che li riguardano – devono essere sempre ascoltati dal Giudice istruttore quando hanno compiuto 12 anni ma anche di età inferiore quando hanno capacità di discernimento. Il Giudice istruttore li ascolta personalmente (c.d. ascolto diretto) ma può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito) in casi delicati. L’ascolto deve avvenire in contraddittorio tra le parti ossia alla presenza dei genitori o, quantomeno, dei loro consulenti e/o Avvocati.
Quali tipi di separazione prevede la legge
La separazione legale si ottiene con la separazione consensuale o la separazione giudiziale.
Come si chiede la separazione
- La separazione consensuale può essere chiesta:
- per la Separazione consensuale in Tribunale con un ricorso che viene depositato nella Cancelleria del Tribunale. Viene fissata un’udienza che può essere svolta con trattazione scritta e pertanto senza l’obbligatoria comparizione personale dei coniugi, generalmente con un avvocato (o ognuno con il proprio avvocato di fiducia), per confermare le condizioni della separazione;
- per la Separazione consensuale nello Studio Legale, senza andare in udienza, con l’Accordo a seguito di procedura di Negoziazione assistita. Gli avvocati scrivono l’accordo insieme ai coniugi. Poi un avvocato si occupa di trasmetterlo – entro 10 giorni – per l’autorizzazione del PM e perché sia poi annotato sull’atto di matrimonio;
- per la Separazione consensuale in Comune dal Sindaco con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Non è però possibile chiedere la separazione in Comune se: ci sono figli minori, o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, o se si vogliono fare trasferimenti patrimoniali (trasferimento di un immobile, di un conto corrente cointestato ecc.). In questi casi, quindi, bisogna utilizzare la separazione in Tribunale o nello Studio Legale con la negoziazione assistita degli avvocati;
- La separazione giudiziale può essere chiesta:
- La separazione giudiziale si chiede in Tribunale con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato. Si incomincia una causa, e alla fine sarà il Tribunale a decidere con una sentenza.
È possibile non concedere la separazione?
Non è esatto dire che sia possibile “non concedere” la separazione. Un coniuge può decidere di non aderire alla richiesta di separazione consensuale, ma se l’altro procede giudizialmente con una causa, il Tribunale pronuncerà la separazione.
Quali sono i diritti del coniuge separato (assegno di mantenimento e assegnazione casa familiare-coniugale) e gli effetti patrimoniali della separazione?
Di seguito alcune conseguenze patrimoniali della separazione:
- il coniuge potrebbe aver diritto ad un assegno di mantenimento, generalmente per la moglie;
- al genitore che vivrà con i figli verrà assegnata la casa coniugale, e avrà diritto di abitarvi fino a quando i figli non vi vivranno più, o saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Il diritto di abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore quindi, in caso di coppia senza figli, sarà molto difficile ottenere un provvedimento di assegnazione, salvo nel caso in cui vi sia un accordo consensuale tra i due coniugi.
- la comunione dei beni si scioglie ed ai coniugi spetta, tendenzialmente, il 50% del corrispettivo dei beni (mobili e immobili) acquistati durante il matrimonio;
Assegno di mantenimento: come si calcola l’assegno per la moglie separata
La moglie che si separa può essere il soggetto economicamente più debole.
Nella separazione però, non sempre la moglie ha diritto all’assegno di mantenimento, specie se è economicamente indipendente ed autosufficiente. Il marito quindi non sarà tenuto a versare un assegno di mantenimento se, ad esempio, la moglie ha delle risorse economiche che le consentono di provvedere al proprio autosostentamento (vitto, alloggio ed esercizio dei diritti fondamentali).
La moglie potrebbe avere:
- un reddito da lavoro dipendente o autonomo (libera professionista, imprenditrice ecc.);
- una rendita finanziaria (interessi sul conto corrente, investimenti in Borsa, capital gain da compravendita di azioni, obbligazioni, future o altri prodotti finanziari, o derivanti da dividendi ecc.);
- una rendita da patrimonio immobiliare (affitto/locazioni di case, uffici, fabbricati, terreni ecc.);
- un aiuto economico dal nuovo partner o dai propri genitori (in entrambi i casi, l’aiuto economico deve però avere un connotato di stabilità, risultando invece ininfluente nel caso ci sia un semplice estemporaneo versamento).
Il marito non è inoltre tenuto a versare l’assegno di mantenimento se la separazione è addebitabile alla moglie (ad esempio in caso di infedeltà o di abbandono del tetto coniugale, ma il tradimento/adulterio/relazione extraconiugale o l’abbandono deve costituire la causa della separazione). L’addebito della separazione può essere chiesto solo con la separazione giudiziale ossia con una causa in Tribunale, e non può essere chiesto nella separazione consensuale.
Per calcolare l’assegno di mantenimento nella separazione non c’è una formula matematica, ma bisogna valutare diversi aspetti, quali:
- la situazione economica, sia patrimoniale che reddituale, di entrambi i coniugi;
- l’età della moglie;
- la durata del matrimonio;
- le condizioni di salute;
- la ridotta capacità di produrre reddito.
In precedenza, la moglie poteva ricevere un assegno che le potesse consentire di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Il tenore di vita era un criterio rilevante. Attualmente il tenore di vita è un criterio marginale, e l’assegno ha solo una funzione assistenziale e compensativa.
Quando si chiedono contestualmente la separazione e il divorzio, la sentenza potrebbe anche decidere di concedere l’assegno di mantenimento per il periodo di separazione e successivamente ridurlo o eliminarlo per il divorzio.
Quando si può chiedere l’addebito e cos’è?
L’addebito della separazione si potrebbe definire come una “sanzione” a carico della moglie o del marito che abbiano tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali (fedeltà, assistenza morale o materiale ecc.)
La domanda di addebito si può fare solo con la separazione giudiziale (e quindi non si può fare né con la separazione consensuale né con il divorzio).
L’addebito viene pronunciato dal Tribunale nella sentenza. È quindi necessario una causa davanti al Giudice nella quale si deve espressamente proporre la “domanda di addebito”. Bisogna inoltre dare la prova che il comportamento (ad esempio infedeltà/tradimento/adulterio/relazione extraconiugale/abbandono del tetto coniugale), costituisce la causa principale della crisi della coppia e dell’intollerabilità della convivenza.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione:
- non ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento (potendo ottenere solo un assegno alimentare, se non ha i mezzi per provvedere al proprio sostentamento).
- perde i diritti in caso di successione, e quindi se l’altro coniuge dovesse mancare, non eredita;
- potrebbe eventualmente essere condannato al risarcimento dei danni.
Separazione con figli
La procedura della separazione non cambia in presenza di figli. Però dovrà essere deciso a quale genitore questi dovranno essere affidati, dove dovranno vivere (e conseguentemente a chi sarà assegnata la casa familiare), nonché i tempi e modi per esercitare il diritto di visita da parte del genitore non collocatario. Bisognerà poi stabilire il contributo per il mantenimento dei figli, sia per le loro spese ordinarie che straordinarie.
Queste decisioni sono agevolate dal “piano genitoriale” un documento che deve essere depositato in Tribunale e deve indicare le attività, la scuola, la gestione dei pomeriggi o delle vacanze. Lo scopo del piano genitoriale è quello di far conoscere al Giudice tutti gli elementi per stabilire l’affidamento, il collocamento e regolare il diritto di visita dei figli minori.
In caso di separazione consensuale questi aspetti verranno decisi concordemente dai coniugi.
In caso di separazione giudiziale provvederà il Tribunale dopo aver assunto le prove necessarie. Ad esempio, in caso di affidamento, potrà essere disposta dal Tribunale una consulenza tecnica. Il Giudice nominerà un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), generalmente uno psicologo o un neuropsichiatra infantile. È quindi importante che ogni genitore abbia, oltre all’avvocato anche un Professionista che possa fare da consulente di parte (CTP). Ogni Studio Legale che fa diritto di famiglia ha un proprio network di Professionisti (psicologi, neuropsichiatri infantili, detective, notai, nonché commercialisti, tributaristi-fiscalisti, esperti d’arte per le valutazioni ecc.) che affiancano l’avvocato prima e durante la procedura di separazione. È quindi importante scegliere un Team di Professionisti che sappia tutelare al meglio i propri diritti, e quelli dei figli.
Separazione senza figli
Quando non ci sono figli, i coniugi dovranno stabilire come dividersi i beni in comune, come procedere ad eventuali trasferimenti immobiliari, somme di denaro, beni (mobili, quadri, gioielli, ecc.) e – nel caso ci siano i presupposti – quanto deve essere l’assegno di mantenimento per il coniuge.
In caso di separazione consensuale si potrà stabilire anche l’assegnazione della casa coniugale a favore della moglie o del marito (a titolo gratuito o pagando un affitto mensile o il mutuo). Ci si potrebbe anche accordare a che la casa sia acquistata da uno dei due coniugi, o che sia messa in vendita, o affittata a terzi.
In caso di separazione giudiziale senza figli, difficilmente il Giudice procederà con un’assegnazione della casa in comproprietà, potendo eventualmente anche suggerire la vendita che, tra l’altro, consente di reperire risorse finanziarie. Meno difficile potrebbe essere la scelta in presenza di una casa in affitto. In tal caso, infatti, non si tratta di un investimento immobilizzato, come per la casa di proprietà. Il contratto d’affitto potrebbe quindi rimanere al conduttore (ossia a chi è intestato il contratto di affitto), oppure potrebbe subentrare nel contratto l’altro coniuge, divenendo quest’ultimo il nuovo intestatario.
Qual è la differenza tra affidamento e collocazione dei figli
L’affidamento è il termine che si utilizza per individuare il genitore che dovrà prendere le decisioni relative alla vita, alla crescita, all’educazione dei figli.
La legge è particolarmente attenta al rapporto tra i figli ed i genitori anche durante la rottura del nucleo familiare. In particolar modo nel 2006 è stata introdotta una legge speciale che privilegia il diritto dei bambini alla bigenitorialità ossia ad avere un continuo, equilibrato e proficuo rapporto con ciascuno dei genitori anche quando questi si separano: per questo motivo nel nostro paese è generalmente preferita una forma di affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Le casistiche di affidamento esclusivo sono molto residuali e attengono a situazioni di grave carenza genitoriale.
La collocazione dei bambini è intesa come il luogo in cui essi vivono prevalentemente che, generalmente è la casa dove prima viveva il nucleo familiare.
Normalmente il Tribunale individua uno dei due genitori con il quale i minori vivranno nella casa familiare. Per l’altro genitore, invece, verranno garantiti i cosiddetti diritti di visita (ovvero dei giorni garantiti durante i quali i bambini dovranno stare insieme al genitore che non vive prevalentemente con loro).
Separazione e calcolo dell’assegno di mantenimento per i figli
Entrambi i coniugi al momento della separazione devono garantire un contributo al mantenimento per i figli che si calcola, tra gli altri criteri, in base alla situazione economica di moglie e marito, del tenore di vita goduto dalla famiglia e dal tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori.
Può essere previsto in forma diretta (ovvero con il pagamento volta per volta della spesa necessaria alla prole) oppure con il versamento di un assegno periodico (generalmente mensile a favore del genitore che vive prevalentemente con i bambini).
L’obbligo di mantenere i propri figli permane indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino a quando non sono economicamente autosufficienti.
I genitori devono cercare di assicurare il rispetto di tutte le esigenze dei figli che vanno oltre le spese alimentari e riguardano anche l’abitazione, la scuola, le attività sportive, le necessità sociali e sanitarie e la predisposizione di un’organizzazione che possa garantire la realizzazione di tutti i bisogni che contribuiscono al loro sviluppo psicofisico.
Nella separazione giudiziale i genitori devono depositare la documentazione relativa ai redditi da lavoro, alle proprietà immobiliari o mobiliari registrate, alle partecipazioni societarie, agli estratti conto, agli investimenti così da dare al Giudice un quadro effettivo sulla loro situazione economica e poter determinare il contributo al mantenimento per i figli.
L’addebito incide sull’affidamento dei figli?
No, l’addebito in sé non ha generalmente conseguenze sulle disposizioni relative ai figli, al loro al loro affidamento e collocazione presso un genitore, tuttavia se la causa di addebito dipende da violenza fisica o psichica, maltrattamenti, o gravi condotte, potrebbe incidere sull’affidamento e sulla collocazione dei figli.
Separazione consensuale: procedura, durata e contenuto accordo
Per la separazione consensuale ci deve essere un accordo sulle condizioni personali e patrimoniali. I coniugi generalmente assistiti congiuntamente da un avvocato, oppure con due Legali diversi, depositano un ricorso al Tribunale competente, di solito quello dell’ultima residenza comune o della residenza dei figli minori.
Il Tribunale, a seguito di un’udienza che può essere trattata anche in modalità cartolare (cioè con trattazione scritta e senza l’effettiva presenza dei coniugi) e dopo aver verificato che le condizioni indicate nel ricorso rispettino i diritti delle parti e dei figli minori, se presenti, emette una sentenza con la quale dispone la separazione consensuale.
I coniugi nella maggior parte dei casi decidono come regolamentare:
- l’affidamento e la collocazione dei figli;
- il diritto di visita del genitore che non convive con i figli;
- l’assegnazione della casa familiare;
- il mantenimento dei figli e del coniuge, ove ne abbia diritto;
- la divisione dei beni (oggetti, mobili ecc.), del patrimonio finanziario (soldi sui conti correnti, azioni, obbligazioni ecc.), soprattutto in caso di comunione dei beni che si scioglie al momento in cui la separazione viene formalizzata dal Tribunale;
- il trasferimento della proprietà di immobili (ossia la proprietà o la comproprietà di una casa che passa da un coniuge all’altro).
L’intervento del Tribunale non è sempre necessario dato che è possibile ottenere la separazione consensuale anche tramite negoziazione assistita, con l’aiuto di un avvocato per parte, o in Comune dinanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato Civile) dopo debita prenotazione presso il Comune di residenza (sebbene con limiti in caso di figli e disposizioni economiche).
Le soluzioni consensuali riducono notevolmente i tempi ed i costi della separazione, basti pensare che per separarsi consensualmente possono essere necessari da venti giorni (negoziazione assistita o Ufficiale di Stato Civile) a due/tre mesi con un ricorso in Tribunale.
Separazione, negoziazione assistita cos’è
Moglie e marito possono chiedere la separazione legale anche senza attendere i tempi della burocrazia dei processi civili, ossia senza recarsi in Tribunale né partecipare ad udienze. Se i coniugi vogliono separarsi consensualmente, infatti, possono avviare la procedura di negoziazione assistita con l’intervento di un avvocato per parte.
Le parti devono accordarsi su tutte le condizioni relative i loro rapporti personali e patrimoniali, comprese le questioni relative ad un eventuale assegno di mantenimento per il coniuge più debole, e riguardanti i figli.
Separazione con negoziazione assistita: quali tempi?
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere inoltrato alla Procura della Repubblica ed autorizzato dal Pubblico Ministero che concede il nulla osta così da poter essere annotato sull’atto di matrimonio.
La separazione in questo caso si ottiene con tempistiche molto ristrette.
Dopo aver individuato tutte le condizioni, anche economiche, che regoleranno i rapporti tra i coniugi e con i figli l’iter si completa dopo circa un mese (ad eccezione di casi in cui la Procura della Repubblica competente sia eccessivamente carica di fascicoli e quindi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni).
La separazione ha pieno valore legale e la data certificata di stipulazione dell’accordo dà inizio al periodo richiesto dalla legge per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Separazione Giudiziale: procedura e durata
Quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, chi è interessato a separarsi deve procedere con la separazione giudiziale.
Il diritto di chiedere la separazione spetta a ciascun coniuge. Marito e moglie, quindi, hanno sempre diritto di separarsi anche nel caso in cui l’altro coniuge non voglia.
Con l’assistenza di un avvocato, un solo coniuge deve depositare un ricorso al Tribunale competente: se ci sono figli minori quello della loro residenza, se invece non si cono figli solitamente è quello di residenza del convenuto o dell’ultima residenza comune.
A differenza della consensuale, quindi, la separazione giudiziale deve essere chiesta obbligatoriamente in Tribunale e viene pronunciata con una sentenza emessa dopo un vero e proprio giudizio.
Dopo il deposito dei rispettivi atti, che devono contenere fin da subito tutte le istanze istruttorie e tutte le produzioni documentali, è prevista un’udienza tenuta dal Giudice istruttore nominato dal Tribunale al termine della quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati. Il Giudice istruttore emette i “provvedimenti provvisori ed urgenti” che disciplinano, di solito fino alla sentenza, i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra i coniugi/genitori. I provvedimenti provvisori ed urgenti riguardano: i figli (affidamento, collocazione, diritto di visita, mantenimento, assegnazione della casa coniugale) e il mantenimento del coniuge che ne abbia diritto.
Può essere anche emessa, se richiesto, una sentenza parziale che pronunci immediatamente la separazione tra i coniugi e decida sulle questioni non controverse, laddove ci siano.
La causa continua davanti al Giudice Istruttore che deve valutare tutte le prove. Nella separazione giudiziale è il Giudice a decidere quali saranno le modalità di separazione con la sentenza finale.
Questi passaggi rendono la procedura molto più lunga di quella consensuale: in media possono passare da due anni e mezzo ai quattro anni per giungere al termine di una separazione giudiziale.
Nel ricorso può essere chiesto contestualmente il divorzio. In questo caso il Giudice istruttore una volta decorsi i termini per la concessione del divorzio (12 mesi dall’autorizzazione a vivere separati) tratta ed esamina anche le domande relative al divorzio emettendo una sentenza che decide sia sulla separazione che sul divorzio.
Cosa significa sentenza parziale di separazione
Durante la separazione giudiziale, per evitare che i coniugi debbano “sopportare” le conseguenze delle lungaggini delle cause civili, è possibile chiedere la pronuncia di una sentenza non definitiva che fin della prima udienza dichiari la separazione della coppia, per poi continuare il procedimento sulle questioni controverse.
La sentenza parziale di separazione quando non viene appellata (passaggio in giudicato) permette di poter chiedere il divorzio anche prima dell’emissione della sentenza definitiva ed ottenerlo durante lo svolgimento del giudizio nel caso in cui si è avanzata domanda contestuale di separazione e divorzio.
Quali sono gli effetti personali della separazione sui coniugi
La separazione non fa cessare il matrimonio né i diritti e doveri che vengono solo attenuati. La separazione produce effetti giuridici sui rapporti patrimoniali e personali dei coniugi.
- Con la separazione, gli obblighi di assistenza e collaborazione vengono a cessare, con l’eccezione di quello che riguarda il diritto al mantenimento o agli alimenti del coniuge più debole;
- l’obbligo di solidarietà tra i due coniugi permane, quanto meno in situazioni particolari come, ad esempio, la malattia o la grave infermità di uno dei due;
- la coabitazione cessa del tutto, pertanto uno dei due coniugi si trasferirà in un’altra abitazione, cambiando la residenza;
- l’obbligo di fedeltà non permane durante la separazione tuttavia, in molti casi, si ritiene che il coniuge separato debba tenere un comportamento tale da non offendere la dignità e la sensibilità dell’altro coniuge, anche quando inizia una nuova relazione. In presenza di figli, specie se minorenni, è necessario adottare alcune accortezze. Sarà necessario una graduale introiezione del nuovo partner, pertanto dovrà essere presentato con sensibilità e delicatezza, aumentando poi progressivamente le occasioni di incontro, senza tuttavia imposizioni. Sarà necessario sempre valutare attentamente le reazioni dei minori. Generalmente si cerca di evitare – quantomeno all’inizio – di andare a convivere con il nuovo partner per non turbare i minori, che potrebbero non comprendere, arrivando ad elaborare un transfer distorto su soggetti e figure genitoriali;
- la moglie può continuare ad utilizzare il cognome del marito anche durante la separazione, fatta eccezione dei casi in cui ritiene che il suo utilizzo le arrechi pregiudizio grave;
- rimangono immutati gli obblighi ed i doveri nei confronti dei figli, tra cui quello di mantenerli, istruirli ed educarli.
Differenza tra coniuge separato e coniuge superstite non separato
Nel caso in cui il coniuge separato muoia, il superstite a cui non è stata addebitata la separazione, mantiene tutti i diritti ereditari del coniuge non separato: egli, in sostanza, è a tutti gli effetti erede del defunto come il coniuge non separato.
Dove si chiede la separazione – Tribunale competente e Comune
La separazione consensuale può essere chiesta nell’ultimo luogo di residenza comune dei due coniugi o dove risiedono i figli minori.
La separazione giudiziale deve essere chiesta nel luogo di residenza dei figli minori o del coniuge convenuto (cioè quello che viene citato in giudizio) se non ci sono figli.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente (cioè di chi incomincia la causa), e se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale in Italia, a scelta.
Quali sono i documenti per la separazione consensuale o giudiziale?
I documenti per la separazione:
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio;
- certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
- copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi, estratti conto e documentazione attestante proprietà immobiliari (nel ricorso possono essere anche solo indicati dettagliatamente).
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti Comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.
In caso di separazione giudiziale, a seconda delle questioni che si dovranno trattare in causa, devono essere depositati i documenti utili a provare lo stato patrimoniale e reddituale delle parti.
A titolo esemplificativo potrebbero essere utili:
- resoconti spese;
- eventuali estratti con movimentazione dei conti correnti italiani ed esteri, conti titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;
- polizze assicurative sulla vita o a capitalizzazione;
- documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero o di altri beni (automobili, barche ecc.);
- contratto di lavoro, buste paghe, benefits percepiti dall’azienda.
In caso sia necessario provare che l’altro coniuge ha delle entrate economiche non dichiarate (c.d. guadagni con soldi in nero), si potrà dare:
- la prova diretta (con testimoni, ricevute ecc.), o attraverso indagini private (detective privato), o chiedendo al Giudice di disporre indagini della Polizia Tributaria (Guardia di Finanza) o di ordinare direttamente al coniuge, oppure a soggetti terzi quali Banche, Società finanziarie, Società italiane ed estere ecc., di depositare la documentazione fiscale, amministrativa, gli estratti dei conti correnti, carte di credito, titoli ecc., o la documentazione relativa ad acquisti di beni ecc.;
- la prova indiretta, dimostrando l’incompatibilità tra quanto indicato nella dichiarazione dei redditi come utile e quanto è l’effettivo tenore di vita del coniuge (spese per automobile, vacanze, ristoranti, barche, oggetti ecc.).
- in presenza di figli il Giudice avrà la possibilità di ammettere prove e chiedere il deposito di documenti anche d’ufficio in mancanza di una domanda diretta delle parti.
Qual è la differenza tra separazione e divorzio
La separazione non pone fine al matrimonio ma ne sospende gli effetti in attesa di una riconciliazione oppure di un procedimento di divorzio.
Il divorzio causa lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, nel caso in cui è stato celebrato un matrimonio concordatario o con rito di una religione diversa da quella cattolica ma riconosciuta dallo Stato italiano).
Solo con il divorzio i coniugi cessano di avere reciproci diritti e doveri sia dal punto di vista personale che patrimoniale con l’unica eccezione di un dovere di assistenza materiale nei confronti dell’ex coniuge economicamente più debole.
Tempo necessario tra separazione e divorzio “breve”
La legge prevede che i coniugi, prima di procedere con il divorzio, debbano restare separati per 6 mesi in caso di separazione consensuale e 1 anno in caso di separazione giudiziale.
Il termine decorre, nella prima ipotesi, dall’udienza di trattazione che viene fissata dal Presidente del Tribunale e, nel secondo caso, dal momento in cui il Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.
Si chiama “divorzio breve” perché ora bastano solo 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o un anno (in caso di separazione giudiziale). Invece, prima della riforma del 2015, era necessario attendere 3 anni dalla separazione prima di poter chiedere il divorzio.
Con la possibilità di chiedere il divorzio contestualmente alla separazione le tempistiche totali si accorciano perché durante il Giudizio appena spira il termine previsto dalla legge si potrà subito ottenere la sentenza parziale sullo status, invece di aspettare ulteriori tempi burocratici per l’inizio di un altro procedimento.
Cosa succede se i coniugi si riconciliano?
Se il procedimento di separazione non è ancora finito, dovrà essere abbandonato ed il Tribunale non procederà ulteriormente.
Se il procedimento di separazione è giunto al termine i coniugi possono decidere di ricominciare la loro relazione affettiva e la coabitazione che già, di per sé, impedisce il sorgere dei requisiti per chiedere il divorzio, oppure far trascrivere la riconciliazione sull’atto di matrimonio dall’Ufficiale di Stato civile.
Separazione, presupposti per la modifica delle condizioni di separazione
Tutte le condizioni stabilite con la separazione, sia consensuale che giudiziale, possono essere modificate nel caso in cui sopraggiungano giustificati motivi. Il procedimento per modificare le condizioni ha una durata variabile che dipende dal grado di conflittualità tra moglie e marito e dall’eventuale accordo sui cambiamenti da introdurre.
Esistono molteplici casistiche che possono causare una legittima richiesta di modifica delle condizioni di separazione. A titolo esemplificativo possiamo citare alcuni tra i motivi più comuni quali la diminuzione del reddito del coniuge obbligato che potrebbe chiedere un abbassamento proporzionale dell’importo dovuto o, viceversa, un miglioramento delle condizioni patrimoniali che potrebbe spingere chi riceve l’assegno a pretendere un aumento.
Anche in questo caso la procedura può essere consensuale o giudiziale e ricalca quelle appena descritte per ottenere la separazione.
Perché è importante affidarsi ad uno Studio legale specializzato in diritto di famiglia, in separazione e divorzio
Prima di incominciare una separazione, è consigliabile consultare un avvocato, preferibilmente esperto in diritto di famiglia (avvocato divorzista, c.d. avvocato familiarista o avvocato matrimonialista).
L’assistenza legale di un avvocato in una separazione giudiziale è obbligatoria. Ci sono, poi, molti aspetti da valutare non solo economici e personali, ma anche processuali e probatori che saranno presi in considerazione dal Giudice per la decisione.
Anche nel caso di una separazione consensuale, è consigliabile avere la consulenza di un avvocato divorzista poiché potrà aiutare i coniugi a trovare un accordo tutelante per entrambi. Lo Studio Legale si occuperà di ogni aspetto della separazione e, a seconda della procedura scelta, si potrà ottenere la separazione consensuale dopo qualche settimana o entro qualche mese.
© Avv. Andrea Marzorati – Vietata la riproduzione anche parziale (tutti i contenuti sono protetti dal diritto d’autore)